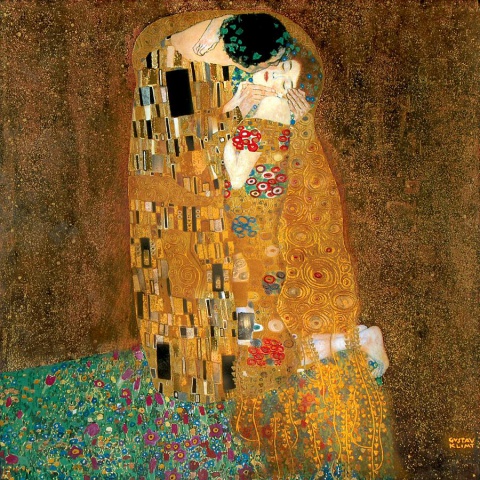
Nell’alveo della psicoanalisi intesa come metodo di trasformazione e conoscenza di sé e della realtà, la cornice teorico/clinica più comprensiva, promettente ed euristica sembra essere quella della psicologia analitica intersoggettiva, evoluzione del pensiero di C. G. Jung elaborata da Silvia Montefoschi e da Paolo Cozzaglio.
Questa visione, in coerenza con tutte le più recenti scoperte neuroscientifiche su livelli di coscienza, attività inconscia della psiche e neuroni specchio, comprende ed articola: il concetto di Soggetto intersoggettivo; diversi livelli possibili di coscienza (semplice, primaria, riflessiva, autoriflessiva, co-riflessiva); la distinzione tra i diversi tipi di relazioni umane (relazioni simbiotiche, interdipendenti, intersoggettive); la fondamentale differenza tra il bisogno (di qualcosa di mancante) e desiderio (generato attivamente e continuamente dal Soggetto nella sua pienezza riflessiva).
Soggetto riflessivo individuale è colui che riesce a prendere distanza dai propri vissuti immediati (dall’Io), a guardarli, interrogarli e riflettervi sopra esercitando la funzione riflessiva (intesa come soggettivazione della funzione trascendente junghiana, continuamente creatrice di sempre nuove sintesi tra coscienza ed inconscio). In questo modo il Soggetto diviene l’organizzatore cosciente della sua stessa personalità.
Il Soggetto intersoggettivo è inteso come un livello di coscienza in cui l’essere umano si vede e si vive Soggetto aperto, presente a se stesso, all’altro Soggetto e alla realtà tutta grazie ad una continua attività di co-riflessione. Il Soggetto intersoggettivo è il livello di coscienza nel quale il Soggetto riflessivo realizza insieme agli altri Soggetti l’essenza incessantemente evolutiva e creatrice degli esseri umani, tessendo finalmente insieme Logos ed Eros, Pensiero e Amore.
Ogni sofferenza psichica è dovuta ad un deficit più o meno grave nella capacità del Soggetto di esercitare la funzione riflessiva. In questa visione il transfert, i meccanismi di difesa, le modalità dell’interpretazione in seduta, l’analisi dei sogni e la cura vengono riletti superando descrizioni limitanti fondate su presupposti positivisti, pulsionali ed omeostatici ormai del tutto superati (il paradigma freudiano). Le relazioni oggettuali divengono finalmente relazioni tra Soggetti; il setting diventa la modalità relazionale terapeutica continuamente pensata dall’analista per aiutare quel paziente a viversi Soggetto della cura; i tipi di personalità vengono descritti, oltre che nei loro tratti e temi complessuali inconsci caratteristici, anche nelle loro diverse sfumature relazionali di dipendenza e interdipendenza; le pulsioni e alcuni concetti trasfusionali (come l’identificazione proiettiva) diventano modalità di essere in relazione legate ai diversi livelli di coscienza di cui i Soggetti possono disporre nel momento della loro interazione; il concetto stesso di personalità viene ripensato in funzione del suo organizzatore unico, distinto dall’Io: il Soggetto. L'Io vive così concepito come la struttura attuale della personalità, il Soggetto come il suo organizzatore continuo.
La psicoanalisi così riletta sembra finalmente diventare una, arricchita, non divisa, dai contributi delle diverse scuole e correnti che, quando vissute in modo chiesastico a livello di coscienza dell’Io, rischiano di diventare piccole sette ortodosse, ognuna col suo linguaggio quasi incomprensibile alle altre. La visione montefoschiana guarda infatti alla psicoanalisi come ad un sapere storico-culturale in continuo divenire, che riflette su di sé e si evolve nel tempo insieme al livello di coscienza raggiunto via via dagli esseri umani.
La tecnica analitica consiste nel mettere sempre “il Soggetto con le spalle al muro”, ponendogli domande (su di sè, la sua quotidianità, le sue relazioni, la sua storia, le sue fantasie, i suoi sogni) che lo aiutino a riflettere su di sè, ad uscire dalla tomba della passività e dei sintomi e a tendere verso la rinascita della sua soggettività e il superamento della modalità relazionale simbiotica o interdipendente. Guarire significa viversi come Soggetto anche del proprio patire. Lungo questa strada l’analista, lontano da ogni artificiosa e difensiva neutralità, si fa presente e pienamente umano proprio vivendosi come Soggetto intersoggettivo al cospetto del paziente, e la psicoanalisi, lungi dal rimanere un sapere complicato, lontano dalla vita e descritto in un linguaggio anatomico e perverso, torna così ad essere uno sguardo profondo che abbraccia l’uomo e il senso stesso della vita e dell'Universo: il cammino dell’Essere verso la coscienza di sé.
p>
